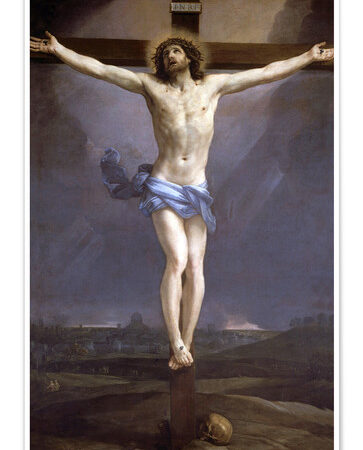Di che sagra sei?
Come fare a orientarsi tra le mille sagre che caratterizzano l’estate? Non c’è angolo di borgo, di paesino o di città che non abbia la sua sagra, l’immancabile associazione che la promuova e un Ente pubblico che la finanzi. È tutto questo è spacciato per la frontiera del turismo serotino estivo. Peccato che una cosa seria si sia ridotta a una moltiplicazione di squallidi eventi che di fatto determinano un danno per il turismo, per la valorizzazione enogastronomica, per la rinascita della cultura rurale e materiale di un territorio. E pensare che il termine sagra deriva dal latino dies sacra, che rappresentava la giornata sacra per antonomasia, quella più importante dell’anno. In alcune regioni era la festa della dedicazione e si caratterizzava con due elementi fondamentali, le danze popolari e il pasto comunitario. Un po’ come le nostre celebrazioni del santo patrono. Quando negli anni recenti c’è stata la riscoperta della sagra, essa svolgeva una funzione di eccezionale promozione sociale e di ottimale marketing. Serviva essenzialmente a riproporre la cultura locale, a riscoprire i sapori dimenticati e i saperi materiali, a promuovere processi di socializzazione attraverso la comunanza di gusti e di valori. Oggi serve soltanto a fare incassi, a distribuire prodotti scadenti, a dare un’offerta di servizi in nero e sottocosto, senza rispetto delle normative sul lavoro, e dell’HACCP ecc. Quando nacque era finalizzata a definire il “tratto identitario” di un centro storico, di un territorio, di uno spazio umano, quell’insieme che costituisce la cultura materiale di un luogo, la quale non si esprime solo nella produzione artistica, architettonica, letteraria e filosofica, ma soprattutto nella vita materiale, sociale ed economica di un gruppo del quale rappresenta il logos relazionale o, se volete, la sua spiritualità. Nel logos relazionale di un determinato luogo si esprimono le risposte che quel gruppo sociale ha saputo dare nel corso dei secoli al bisogno di cibo, alle esigenze del lavoro, alle domande della vita, alle necessità di riposarsi o al desiderio di giocare e di divertirsi. È uno spazio valoriale d’identità nel quale l’individuo che vi appartiene ritrova se stesso e il suo desiderio di “sicurezza” di fronte all’anomia di una cultura globalizzata, uniformemente elitaria o uniformemente di massa. Ha rappresentato la riscoperta di un territorio con le sue tradizioni sedimentate nella cultura materiale, motore dell’attuale e futuro turismo integrato. Il successo del turismo integrato e antropologico, di cui quello enogastronomico è l’esantema più evidente, si deve alla cultura materiale di un determinato spazio umano, espressa nel cibo e nelle leggende, negli strumenti e nelle produzioni tipiche, nelle credenze religiose e nell’arte (povera o alta che sia), nelle specificità urbanistiche e nelle presenze archeologiche, nella flora e nella fauna. Il localismo si riappropria della materialità culturale e può ben accompagnare i processi di riavvicinamento ai valori esperienziali e di recupero dell’emotiva relazione con quelli sedimentati nella personalizzazione delle “cose”. Tutto questo non è né localismo, né cultura locale; è cultura tout court nella molteplicità delle sue manifestazioni. E non ha niente a che vedere con la molteplicità delle sagre che tormentano i nostri mesi estivi e uccidono turismo, enogastronomia e, perché no, anche il nostro stomaco non aduso a pessimi cibi. La sagra è nata per esprimere le esigenze culturali di una comunità territoriale e mostrare verso l’esterno la propria identità. Il suo legame vero è con il turismo e la specificità culturale ed economica di un’area antropologicamente definita. Proprio questa dimensione di autenticità costituisce un importante fattore turistico. Sarebbe ora che la Regione emanasse una normativa per fissare i criteri e le caratteristiche perché una sagra possa essere considerata tale, criteri ai quali ogni Comune debba attenersi per adottare il relativo Regolamento per le autorizzazioni di competenza. Importante è che ci sia un legame tra economia tradizionale, cultura e prodotto territoriali, evitando che nella patria del Fiano o dell’Aglianico ci sia la sagra della birra e a Pisciotta, magari, quella del salmone. E soprattutto che l’evento si svolga nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene, della normativa del lavoro e fiscale; che unisca ricreazione e cultura territoriali, gli attori siano soltanto gli operatori della filiera gastronomica del territorio e il servizio svolto dal personale qualificato della filiera. Ma una Regione, che dopo undici anni non riesce a darsi una qualsiasi legge sul Turismo, sarà mai capace di regolamentare, qualificare e valorizzare la Sagra?